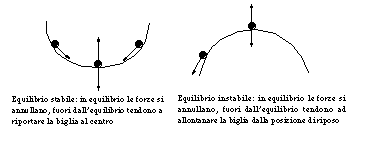Teorie del ciclo economico
2 Equilibrio, instabilità e ciclo
Nel precedente capitolo abbiamo suggerito che le teorie sul ciclo economico, con le corrispettive proposte di politica economica, forniscono una guida interpretativa del momento recessivo in corso e dei dibattiti politici che vi ruotano attorno. Ma quale chiave di lettura occorre adottare?
Quella che ci accingiamo a discutere in questo volume non è certamente la prima storia delle teorie del ciclo economico. Nella letteratura vi sono innumerevoli esempi di monografie, analisi critiche e rassegne (alcune generiche, altre focalizzate su epoche, paesi o temi specifici, altre ancora ristrette agli sviluppi più recenti), cui vanno aggiunte le interpretazioni della letteratura precedente che quasi ogni proponente di una nuova spiegazione del fenomeno ha ritenuto di dover proporre, al fine di distinguere il proprio approccio e le proprie conclusioni da quelli concorrenti.
Nonostante questa abbondanza, tuttavia, la situazione non è ancora soddisfacente. Questi studi raggruppano le teorie a seconda delle cause via via invocate per spiegare l'insorgere e il perpetuarsi delle fluttuazioni economiche, a seconda che esse siano legate alla moneta, al sottoconsumo o al sovrainvestimento, a cambiamenti tecnologici, a fattori psicologici, a sproporzioni settoriali, ai rendimenti alterni della produzione agricola, e così via. Questi contributi sono molto importanti, in quanto permettono di cogliere alcune delle similitudini di fondo tra diversi approcci teorici e al contempo di distinguere correnti diverse entro il medesimo approccio. Ad esempio, le
teorie del sottoconsumo
, secondo le quali causa delle crisi risiede nell'incapacità del sistema economico di assorbire la produzione totale, nascono in ambito classico, sono riprese da alcune correnti marxiste ma anche da alcuni filoni `sotterranei' di eretici negli anni tra le due guerre mondiali, e il loro germe di verità è stato rivalutato dall'analisi keynesiana così che ancora dopo
Keynes
questa spiegazione non è andata in disuso.
Al contempo, tra i marxisti erano in voga anche altri approcci, come ad esempio le sproporzioni settoriali.
2.1. L'equilibrio e l'impossibilità del movimento
Pur senza voler negare l'utilità delle ricostruzioni storiche delle teorie del ciclo fin qui proposte, qui seguiremo un diverso approccio, che nasce dall'osservazione di
Hayek
secondi cui le classificazioni più recenti (siamo alla fine degli anni venti, ma la situazione non sembra essere mutata) erano lungi dall'essere teoricamente soddisfacenti, in quanto lasciavano un eccessivo margine di discrezionalità su cosa andasse incluso o meno in un ciascuna categoria. Riprendendo una riflessione di
Adolf Löwe
(
Löwe 1925
, p. 359), Hayek sostiene che "la sola classificazione che realmente non lascerebbe spazio ad obiezioni dovrebbe considerare il modo in cui tali teorie [del ciclo] spiegano l'assenza del `corso normale' degli eventi descritto dalla teoria statica" (
Hayek 1933
, pp. 53-54).
L'analisi economica cui si riferisce Hayek (quella che oggi denominiamo neoclassica) rappresentava --pur con notevoli differenze tra una scuola e l'altra-- i sistemi economici in termini di equazioni o diagrammi che esprimevano le relazioni tra prezzi e quantità dei vari beni e fattori della produzione. La soluzione di queste equazioni (o, corrispondentemente, le intersezioni tra le varie curve nei diagrammi) esprimevano uno stato di equilibrio del sistema, vale a dire una configurazione di prezzi e quantità prodotte tale da soddisfare tutti gli agenti economici e non mettere dunque in moto stimoli che spingessero al cambiamento. Secondo Hayek e gli altri autori neoclassici, questo modello algebrico o geometrico (seppure semplificato) rappresenta il `corso normale' degli eventi.
Evidentemente, in una visione di questo genere non vi è spazio per le crisi o per il ciclo economico: un equilibrio statico non ammette nessuna forma di movimento, e parlare di ciclo è una contraddizione in termini. Löwe (come vedremo meglio in un prossimo capitolo) aveva esplicitato questa critica, e Hayek ne ha riconosciuto la validità, osservando che al contrario le altre teorie del ciclo non avevano affrontato il cuore del problema: quello, cioè, di spiegare in quale modo sia possibile allontanarsi dallo stato di equilibrio. Come vedremo, la parziale soluzione proposta da Hayek risente dei limiti stessi del suo approccio;
il problema da lui ripreso è però reale ed importante, così come è innovativa la sua proposta di prendere come chiave di lettura delle teorie del ciclo le soluzioni (o la mancanza di soluzioni) via via proposte dai vari autori in diversi contesti teorici. È necessario, però, formulare il problema in modo più preciso.
2.2. La stabilità dell'equilibrio, e l'endogenità del movimento
Occorre innanzitutto specificare il significato del termine `equilibrio'. Nonostante questa nozione sia centrale nel discorso economico, essa è una delle più ambigue, in quanto le sono stati associati diversi significati dalle implicazioni alquanto diverse.
La caratteristica comune, piuttosto intuitiva, che qui ci interessa mettere in evidenza, può essere formulata nel linguaggio della meccanica --disciplina da cui gli economisti hanno mutuato parecchi concetti entrati nel loro strumentario abituale: sono detti di equilibrio gli stati di un sistema in cui le varie forze endogene in gioco si annullano reciprocamente. In equilibrio e in assenza di disturbi esterni non vi è dunque tendenza al cambiamento;
per contro, in disequilibrio le forze (cause del movimento) non si annullano reciprocamente e il sistema presenta una dinamica endogena.
Il passo successivo consiste nello stabilire se il movimento al di fuori dell'equilibrio, causato, ad esempio, da un disturbo accidentale, tenda a ricondurre il sistema verso l'equilibrio oppure se tenda ad allontanarlo ulteriormente da tale stato. Nel primo caso si parlerà di equilibrio stabile, nel secondo di equilibrio instabile
(in senso dinamico).
Un semplice esempio basta ad illustrare questo concetto. Una biglia in una ciotola è un sistema con un unico equilibrio stabile: la biglia tende a posizionarsi sul fondo della ciotola; se disturbata, oscilla per qualche tempo, ma poi torna al suo stato di equilibrio. Anche una biglia sistemata con perizia sopra una ciotola rovesciata è in uno stato di equilibrio; ma questo equilibrio è altamente instabile: basta un nonnulla, e la biglia inizia a scendere lungo il fianco della ciotola con velocità sempre maggiore, allontanandosi sempre più dal punto di equilibrio. (v. diagramma).
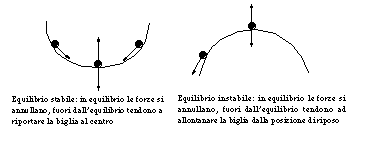
Accoppiando al concetto di equilibrio quello di stabilità possiamo riformulare il problema della possibilità di movimento e della sua permanenza in modo più generale. Consideriamo dapprima un sistema stabile. La nostra biglia non è, naturalmente, condannata all'immobilità: semplicemente essa non è in grado di muoversi da sola. Una forza esterna potrebbe tuttavia farla oscillare attorno al suo punto di equilibrio. Queste oscillazioni, tuttavia, dopo qualche tempo cesserebbero, a meno che non intervenga un'altra forza esterna a ridare energia alla nostra biglia: lo stato per così dire naturale di questo semplice sistema, se non disturbato, è il riposo. Al contrario, la condizione normale di un sistema instabile è il movimento, mentre il riposo è un caso improbabile: se anche qualche forza esterna (un abile giocoliere) ponesse la biglia sul colmo della ciotola, essa non ci rimarrebbe a lungo, a meno che non vi sia trattenuta.
La descrizione del movimento (e pertanto anche del ciclo), dunque, non è un'impossibilità. Ma esso avviene e si mantiene in condizioni ben diverse a seconda della stabilità o instabilità del sistema: nel primo caso è necessaria una forza esterna (esogena) per spiegare la lontananza dall'equilibrio, nel secondo caso è la dinamica stessa del sistema che giustifica (endogenamente) il movimento.
2.3. Ortodossi e critici
Un'analisi delle spiegazioni delle crisi e del ciclo a partire dalla nozione di stabilità dell'equilibrio conduce a riconoscere due grandi linee di approccio, alternative e non conciliabili. Che il capitalismo sia capace di qualche tipo di equilibrio è riconosciuto da tutti: infatti esso esiste. Ma alcuni -l'ortodossia economica- pensano che questo equilibrio sia stabile, e corrispondentemente interpretano il ciclo e le crisi come deviazioni anormali, che non sussisterebbero se non come conseguenza di attriti, dell'ingerenza del governo e delle istituzioni nel meccanismo economico, o altre cause esterne. La loro preoccupazione è di spiegare i cicli come oscillazioni attorno all'equilibrio, e di trovare qualche meccanismo che spieghi come queste cause esterne diano luogo ad un ripetersi periodico e semi-regolare di questi eventi.
Gli eretici, al contrario, ritengono che l'equilibrio sia un caso e che disordine e disoccupazione siano la norma. Il fenomeno da spiegare non è dunque tanto la lontananza dall'equilibrio, quanto piuttosto il fatto che le oscillazioni siano -almeno temporaneamente- contenute entro certi limiti, oltre i quali il sistema si disintegrerebbe e trasformerebbe in qualcos'altro, e come l'interazione tra questi limiti e l'instabilità del sistema dia luogo ad un ripetersi più o meno regolare del fenomeno.
2.4. Il mondo e il modello
L'analisi della stabilità non si applica però direttamente ai sistemi economici, ma ai modelli che gli economisti usano per interpretarli. La conoscenza di un sistema complesso come quello economico, infatti, non può procedere in modo immediato, ma deve far ricorso a modelli: che si tratti di costrutti mentali verbali o di sistemi matematici, essi esprimono le relazioni tra i dati e le variabili che il teorico ritiene essere fondamentali e permettono di trarre delle conclusione sul comportamento di queste variabili. Alcuni di questi comportamenti risultano essere di equilibrio, e delle corrispondenti configurazioni occorre studiare la stabilità o l'instabilità. Ma è necessario tenere presente che le decisioni del ricercatore su ciò che è pertinente dipendono dal problema in esame, e vanno valutata rispetto a quel problema: un diverso problema può richiedere di riconoscere in altro modo quali siano le variabili dipendenti, indipendenti, e quali i dati. Ciò che è esogeno e ciò che è endogeno non è dato una volta per tutte, ma dipende dalle circostanze, dal fenomeno che ci si propone di spiegare, e dal punto di vista dell'osservatore.
Tra il modello e il mondo che esso vuole interpretare non esiste un nesso diretto: il loro rapporto è mediato dalle decisioni del ricercatore che ha formulato il modello su cosa sia o meno pertinente nella spiegazione del fenomeno in esame. Le conclusioni sulla stabilità o instabilità dell'equilibrio non riguardano dunque il mondo, ma solamente il modello.
Esse riflettono tuttavia ciò che l'economista pensa dei sistemi economici. Se un modello rappresenta un equilibrio stabile (o viceversa), non significa necessariamente che il mondo sia effettivamente in un tale stato; ma è chiaro che l'economista che, sulla base di quel modello, legge il mondo e formula dei suggerimenti di politica economica, pensa che il sistema economico tenda verso una tale soluzione.
Per questa ragione non discuteremo delle cause immediate del ciclo né classificheremo le teorie sulla base delle spiegazioni che esse propongono, ma ci occuperemo delle opinioni che gli economisti hanno sulla relazione tra la struttura del sistema e la tendenza all'equilibrio o al disequilibrio, e della pertinenza delle loro scelte quanto ai modelli in base ai quali interpretano il mondo.
Questo articolo è apparso in Azione (settimanale di Lugano) il 20 febbraio 2002. ©
Daniele Besomi
Torna a inizio pagina
Vai all'indice pagina precedente
pagina successiva